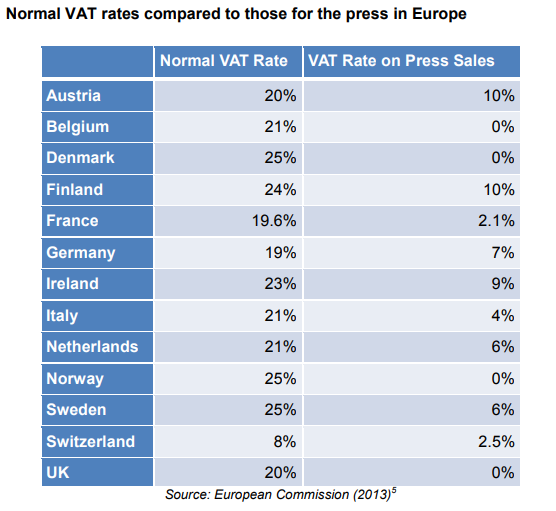Il Dizionario Filosofico fu pubblicato anonimo nel 1764 con data di Londra, ma stampato a Ginevra, con il titolo originale “Dizionario filosofico portatile”. Un tascabile ante litteram , potremmo dire.
I bersagli
Metafisica studiata nelle scuole, assurdità della religione, abusi politici e sociali. Il ruolo dell’intellettuale nei confronti di questi temi si delinea più che mai nel Dizionario Filosofico, che per certi versi diventa anche un Prontuario all’azione, preludio forse all’engagement di natura più spiccatamente novecentesca.
Il segreto dell’efficacia sta sia nel formato tascabile, sia nel tono scherzoso con il quale vengono affrontate le tematiche bibliche.
Il sostegno all’Enciclopedia
L’opera vuole dare implicitamente sostegno all’Enciclopedia di Diderot e D’Alembert. Sebbene si sappia che il pubblico illuminato non potrà che essere minoritario, il tentativo verso la divulgazione è evidente, e a contrasto pure evidente contro l’elitismo e la massoneria dei saperi.
La prima voce, “abate”
Per iniziare sulla scorta dell’anticlericalismo, la prima è voce è nientemeno che “abate”. Il tono, decisamente ironico e parodistico. “L’abate spirituale era un povero e guidava molti altri poveri; ma i poveri padri spirituali ebbero in seguito ducento, quattrocentomila lire di rendita; e oggi in Germania ci sono dei poveri padri spirituali che hanno un reggimento di guardie!” Non è difficile intuire l’ironia ripetuta sottesa a questa iconica descrizione.